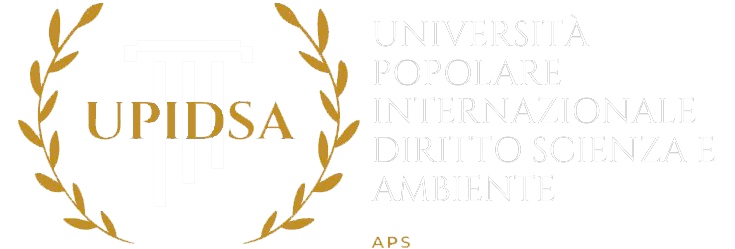Cosa sono le sostanze pericolose nel diritto ambientale? La gestione delle sostanze pericolose è un pilastro fondamentale del diritto ambientale. Attraverso regolamenti dettagliati e controlli rigorosi, l’Unione Europea e l’Italia cercano di bilanciare l’uso delle sostanze chimiche con la protezione della salute e dell’ambiente.
In questa guida vediamo quali sono i principali regolamenti e normative e facciamo il punto sul complesso quadro delle normative satellite che regolamentano in maniera autonoma l’amianto, le radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, il trasporto ADR di merci pericolose, i biocidi, i policlorodifenili e policlorotrifenili etc..
Contents
Cosa sono le sostanze pericolose e perché rappresentano un rischio?
Le sostanze pericolose sono composti chimici o miscele che, per le loro caratteristiche fisiche, chimiche o tossicologiche, possono provocare danni alla salute umana, all’ambiente o alle cose. Possono essere infiammabili, corrosive, cancerogene, tossiche, sensibilizzanti, oppure pericolose per gli organismi acquatici o per la qualità dell’aria e del suolo. Alcune di esse sono presenti nei prodotti industriali, altre si formano durante i processi di produzione o di smaltimento dei rifiuti.
La pericolosità di una sostanza non dipende solo dalla sua composizione, ma anche dalla quantità, dal tipo di esposizione, dalla durata del contatto e dalla modalità con cui viene gestita. Per questo motivo, è fondamentale che la legge stabilisca criteri precisi per identificarle, classificarle, etichettarle, limitarne l’uso e garantirne lo smaltimento sicuro.
Come si misura la pericolosità: criteri tecnico-scientifici
La valutazione della pericolosità di una sostanza si basa su parametri scientifici stabiliti a livello europeo e internazionale. Le autorità competenti si servono di dati sperimentali, studi tossicologici e modelli previsionali per determinare gli effetti potenziali sulla salute e sull’ambiente.
Le sostanze vengono classificate in base a categorie di rischio: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti, pericolose per l’ambiente acquatico, e così via.
L’etichettatura delle sostanze segue un sistema di pittogrammi (simboli di pericolo) e frasi di rischio (H, hazard statements) che permettono a chi le maneggia o le acquista di capire immediatamente i potenziali pericoli. Questo sistema è oggi armonizzato a livello globale attraverso i criteri del GHS (Globally Harmonized System).
Le normative europee principali: REACH e CLP
Il quadro normativo europeo sulle sostanze pericolose si basa su due pilastri fondamentali: il Regolamento REACH e il Regolamento CLP.
Il Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), entrato in vigore nel 2007, stabilisce le regole per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche immesse sul mercato dell’Unione Europea. Il principio alla base di REACH è chiaro: “No data, no market” (senza dati, niente mercato). Le aziende devono fornire informazioni dettagliate sulle sostanze che producono o importano, dimostrando che possono essere usate in sicurezza. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) supervisiona l’applicazione del regolamento.
Il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008) ha il compito di uniformare la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si basa sul sistema GHS delle Nazioni Unite e garantisce che i pericoli siano comunicati in modo chiaro e riconoscibile in tutta l’Unione Europea. Le aziende devono classificare le proprie sostanze secondo criteri precisi e aggiornare costantemente le etichette, i simboli e le schede di sicurezza.
Le normative settoriali: regole specifiche per casi particolari
Oltre a REACH e CLP, esistono normative specifiche – chiamate “satellitari” – che disciplinano in modo autonomo alcuni gruppi di sostanze particolarmente pericolose o situazioni ad alto rischio. Di seguito una panoramica delle principali.
- Amianto: vietato in Italia dal 1992, è regolato dal D.Lgs. 257/2006 e da altre disposizioni specifiche che impongono bonifiche, mappature e controlli rigorosi nei luoghi contaminati. L’esposizione all’amianto è collegata a gravi malattie respiratorie.
- Radiazioni ionizzanti e rifiuti radioattivi: disciplinati dal D.Lgs. 101/2020, che recepisce direttive europee in materia di protezione sanitaria dalle radiazioni. Regola l’uso, il controllo e la disattivazione di materiali radioattivi in ambito medico, industriale e nucleare.
- Trasporto ADR di merci pericolose: regolato dall’Accordo ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e dal D.Lgs. 35/2010. Stabilisce norme tecniche di sicurezza per l’imballaggio, l’etichettatura, la documentazione e i mezzi di trasporto.
- Biocidi: regolati dal Regolamento UE 528/2012, che si applica a sostanze chimiche usate per distruggere organismi nocivi (come disinfettanti, insetticidi, conservanti). Ogni biocida deve essere autorizzato sulla base di un’attenta valutazione del rischio.
- Policlorodifenili (PCB) e Policlorotrifenili (PCT): regolati dalla Legge 62/2005 e da regolamenti europei. Queste sostanze sono molto persistenti e pericolose per l’ambiente; il loro uso è ormai vietato, ma è ancora necessario gestire correttamente gli impianti e le apparecchiature che le contengono.
- Sostanze pericolose nei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): la Direttiva RoHS (2011/65/UE) limita l’uso di piombo, mercurio, cadmio e altre sostanze nei dispositivi elettronici, per ridurre l’inquinamento e favorire il riciclo sicuro.
- Incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose: disciplinati dal D.Lgs. 105/2015 (che recepisce la Direttiva Seveso III). Le industrie a rischio devono adottare misure preventive, piani di emergenza e sistemi di informazione pubblica in caso di incidenti industriali gravi.
Perché è importante conoscere queste norme?
Le norme sulle sostanze pericolose non servono solo agli addetti ai lavori, ma proteggono anche la salute dei cittadini, la sicurezza dei lavoratori e la qualità dell’ambiente. Conoscere i rischi e sapere come vengono gestiti aiuta a prevenire contaminazioni, malattie professionali, incendi, esplosioni e danni irreversibili agli ecosistemi.
Inoltre, l’informazione e la trasparenza sulle sostanze pericolose sono diritti riconosciuti a livello europeo: ogni cittadino ha la possibilità di accedere a dati pubblici sulle sostanze registrate, consultare le etichette dei prodotti e partecipare ai processi decisionali in materia ambientale.