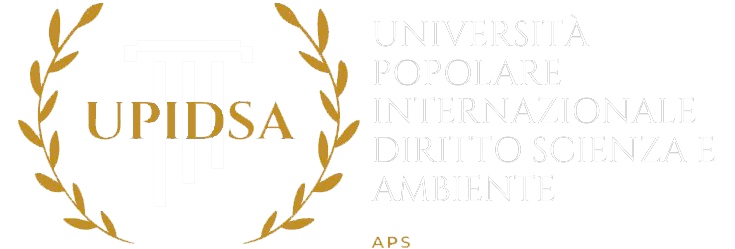In questa guida parliamo del piombo, un metallo pesante altamente tossico. L’esposizione al piombo è molto dannosa e causa gravi danni alla salute del feto, dei bambini e degli aldulti compromettendo diversi organi. Vediamo dove si trova il piombo, dove è usato e quali sono le categorie di lavoratori a rischio. Vediamo nel dettaglio quali sono gli effetti sulla salute dell’esposizione al piombo e cosa fare in caso di esposizione.
I lavoratori esposti che abbiano contratto una malattia correlata hanno diritto al riconoscimento di malattia professionale o causa di servizio, a seconda del settore d’impiego. Al riconoscimento sono connessi rendite o indennizzi. I lavoratori hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti. Quindi oltre al danno biologico anche quelli patrimoniali ed esistenziali e morali. In caso di morte del lavoratore i famigliari eredi legittimi hanno diritto alla reversibilità delle somme maturate dal lavoratore in vita e al risarcimento dei danni. Compresi i danni subiti iure proprio.
Upidsa si occupa di formare un personale in grado di promuovere ambienti di lavoro sicuri e al riparo da esposizioni dannose. Di fornire inoltre informazioni e supporto alle vittime e ai famigliari, per quanto riguarda la prevenzione a 360°. In particolare con un focus sulla prevenzione terziaria e sulla tutela legale dei lavoratori esposti.
Contents
- 1 Che cos’è il piombo? Storia e definizione
- 2 Dove si trova il piombo? In natura e nei luoghi di vita
- 3 Effetti sulla salute del piombo: danni e rischi
- 3.1 Saturnismo: cos’è e come si manifesta?
- 3.2 Intossicazione acuta nei bambini e negli adulti
- 3.3 Cos’è la piombemia e quali sono i sintomi?
- 3.4 Livelli di esposizione al piombo: la soglia di esposizione
- 3.5 Come si fa la diagnosi di intossicazione?
- 3.6 Esami per monitorare l’esposizione in adulti e bambini
- 3.7 Trattamenti per l’esposizione: quali sono?
- 4 Chi è maggiormente a rischio? Le categorie lavorative a rischio
Che cos’è il piombo? Storia e definizione
Il piombo, noto e utilizzato fin dall’antichità, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo di diverse civiltà, ma oggi è principalmente associato ai rischi per la salute e l’ambiente.
Ma che cos’è? Il piombo è un elemento chimico, identificato con il simbolo Pb e il numero atomico 82 nella tavola periodica. Questo metallo pesante si distingue per la sua densità elevata, la facilità con cui può essere lavorato e la sua resistenza alla corrosione. Se lo si osserva appena tagliato, appare di un colore grigio-bluastro che tende a scurirsi con il tempo a causa dell’ossidazione.
In termini chimici, il piombo è un metallo relativamente stabile, che non si dissolve facilmente in acqua e resiste all’azione degli agenti atmosferici. Tuttavia, reagisce con acidi forti e basi, liberando sostanze potenzialmente dannose. È proprio questa combinazione di utilità pratica e tossicità a renderlo un elemento utilizzato e al contempo pericoloso.
L’intossicazione da piombo può manifestarsi in forma acuta, con sintomi violenti come dolori addominali, vomito e convulsioni, oppure in forma cronica, dove il metallo si accumula lentamente nel corpo causando danni cumulativi. Questo secondo tipo di esposizione è particolarmente insidioso, poiché i sintomi possono emergere solo dopo anni.
Dove si trova il piombo? In natura e nei luoghi di vita
In natura, il piombo non si presenta quasi mai allo stato puro. È invece comune trovarlo sotto forma di minerali, tra cui il più diffuso è la galena, un solfuro di piombo. Altri minerali importanti sono la cerussite e l’anglesite, dai quali il piombo viene estratto e purificato attraverso processi industriali. Le riserve naturali di piombo si concentrano principalmente in paesi come Cina, Australia, Stati Uniti e Russia.
Nella vita quotidiana, il piombo ha trovato impiego in una vasta gamma di prodotti e applicazioni. In passato era usato comunemente nelle vernici, poiché conferiva maggiore durata e vivacità ai colori. Oggi, nonostante i divieti, potrebbe ancora essere presente in vecchi edifici o oggetti antichi. Anche i tubi idraulici contenevano spesso piombo, il che significa che tracce di questo metallo possono trovarsi nell’acqua potabile, specialmente nelle case più datate.
Il piombo è ancora utilizzato nella produzione di batterie per automobili, nei cristalli di alta qualità e nei decanter, dove conferisce brillantezza. Inoltre, viene impiegato in alcuni dispositivi elettronici, nelle munizioni, nei pesi da pesca e come materiale schermante contro le radiazioni, ad esempio nelle strutture sanitarie.
Dove potrebbe trovarsi in casa il piombo?
Il piombo può essere sorprendentemente vicino a noi, spesso in modi inaspettati. Nelle case costruite prima degli anni Settanta, è possibile che le vecchie vernici contengano piombo. Questo rappresenta un rischio particolare quando la vernice si deteriora, rilasciando polvere o scaglie. Anche i tubi idraulici vecchi possono essere una fonte di contaminazione: sebbene il piombo sia stato sostituito con materiali più sicuri, in alcune abitazioni più antiche potrebbero ancora esserci giunture in piombo che rilasciano particelle nell’acqua potabile.
Anche alcuni oggetti decorativi possono rappresentare un rischio. Bicchieri o decanter in cristallo contenenti piombo possono rilasciare piccole quantità di metallo nelle bevande, specialmente se queste sono acide. Lo stesso vale per alcune ceramiche smaltate. Infine, giocattoli antichi o oggetti provenienti da paesi con normative meno rigide potrebbero contenere piombo in quantità pericolose.
Il piombo nei luoghi di lavoro: dove?
Nei luoghi di lavoro, la presenza di piombo è particolarmente diffusa in ambiti industriali. Chi lavora nelle fonderie, ad esempio, può essere esposto a polveri o fumi di piombo durante i processi di fusione. Lo stesso vale per i minatori, che maneggiano direttamente i minerali grezzi. Negli impianti di riciclo, il piombo può essere rilasciato durante il trattamento di batterie esauste o apparecchiature elettroniche, mentre nell’edilizia si può entrare in contatto con questo metallo durante le demolizioni o i restauri di vecchi edifici.
Come proteggersi dall’esposizione da piombo in casa
Se si vive in una casa costruita prima del 1978 si raccomanda di far controllare da un professionista la casa e il terreno che la circonda. Buone abitudini da tenere a mente:
- passare lo straccio di frequente su pavimenti e superfici per moderare la quantità di polvere;
- rimuovere la polvere da tappeti e tappezzeria e usare un filtro HEPA se possibile;
- verificare mensilmente che non vi siano scheggiature, superfici senza rivestimento, o altre superfici danneggiate soprattutto nelle zone di finestre e portici;
- riparare e ripulire accuratamente la zona per rimuovere la polvere ricca di piombo;
- imparare come rinnovare e riparare lavorando in modo sicuro in modo da non creare più polvere carica di piombo e ulteriore contaminazione.
Per i bambini invece si raccomanda di:
- lavare loro le mani e i giocattoli frequentemente, in modo da ridurre la contaminazione con polvere carica di piombo;
- allontanarli (così come le donne in gravidanza) dalle zone contaminate da piombo e dalle zone di ristrutturazione;
- non lasciare che si infilino oggetti in bocca che non sono utilizzabili come giocattoli, incluse le chiavi e i gioielli;
- far testare i bambini a 1 e a 2 anni d’età, contattando l’ASL di riferimento.
Come proteggersi dall’esposizione da piombo a lavoro
Se si lavora in un ambiente potenzialmente pericoloso per l’esposizione alle polveri o al fumo con piombo si raccomanda di:
- lavarsi le mani prima di mangiare, bere o fumare;
- mangiare, bere e fumare in zone che sono libere dalla polvere e dai fumi di piombo;
- indossare un respiratore con filtro HEPA (classe N-100) e radersi la barba per ricavarne i benefici migliori;
- tenere i propri abiti non da lavoro in un posto pulito;
- cambiare vestiti e scarpe prima di lavorare con il piombo;
- Fare immediatamente una doccia dopo aver lavorato col piombo e prima di andare a casa;
- lavare i vestiti da lavoro sul posto di lavoro o separatamente da quelli degli altri membri della famiglia.
Effetti sulla salute del piombo: danni e rischi
Il piombo è altamente tossico e non ha alcuna funzione benefica nell’organismo umano. Una volta ingerito, inalato o assorbito attraverso la pelle, può accumularsi nel corpo, danneggiandolo. I suoi effetti dipendono dalla quantità e dalla durata dell’esposizione, ma anche piccole dosi possono causare problemi gravi se il contatto è prolungato.
Uno dei principali bersagli del piombo è il sistema nervoso. Nei bambini, l’esposizione può portare a ritardi nello sviluppo cognitivo, difficoltà di apprendimento, problemi comportamentali e una riduzione del quoziente intellettivo. Negli adulti può causare neuropatie, con sintomi come debolezza muscolare, perdita di sensibilità e problemi di coordinazione.
Anche il sistema ematologico è particolarmente vulnerabile. Il piombo interferisce con la produzione di emoglobina, portando ad anemia e causando sintomi come stanchezza e debolezza cronica. I reni, a loro volta, possono subire danni irreversibili, con il rischio di sviluppare insufficienza renale cronica.
Sistema cardiovascolare: è associato a un aumento della pressione arteriosa e al rischio di malattie cardiache. Sul piano riproduttivo, può compromettere la fertilità sia negli uomini che nelle donne e, in gravidanza, attraversare la placenta, esponendo il feto a danni permanenti (embriotossicità del piombo).
Lo IARC inserisce il piombo tra i patogeni appartenenti al Gruppo B2 (possibilmente cancerogeni).
Saturnismo: cos’è e come si manifesta?
L’intossicazione cronica da piombo, nota con il termine saturnismo, è una condizione che si sviluppa principalmente in ambito professionale, dove l’esposizione al metallo è più frequente. Questa forma di avvelenamento può provocare una serie di disturbi, tra cui anemia (un pallore legato alla riduzione dei globuli rossi), dolori addominali noti come coliche intestinali, pressione alta, difficoltà nei movimenti manuali e un rallentamento dei riflessi. Altri effetti includono danni ai reni (nefropatia) e al sistema nervoso (neuropatia).
Nei casi più gravi, sebbene oggi siano rari, l’esposizione acuta può portare a danni cerebrali (encefalopatia) e persino al coma.
Intossicazione acuta nei bambini e negli adulti
Nei bambini, l’esposizione acuta può manifestarsi con irritabilità, difficoltà a mantenere l’attenzione e sintomi neurologici severi come l’encefalopatia. Dopo alcuni giorni, possono insorgere edema cerebrale, vomito continuo, difficoltà a camminare, convulsioni e alterazioni dello stato di coscienza, che possono evolvere in un coma. Prima che questi sintomi compaiano, spesso ci sono segnali premonitori come irritabilità prolungata e una riduzione dell’interesse per il gioco. In forma cronica, può causare ritardi nello sviluppo mentale, disturbi comportamentali, crisi epilettiche, dolori addominali persistenti e anemia.
Negli adulti esposti per motivi professionali, l’intossicazione si sviluppa più lentamente, spesso nell’arco di settimane o mesi. I sintomi possono includere mal di testa, cambiamenti nel comportamento, dolori addominali e danni al sistema nervoso. L’encefalopatia negli adulti è piuttosto rara, ma altri effetti possono includere la perdita del desiderio sessuale, problemi di fertilità e, negli uomini, disfunzioni erettili.
Cos’è la piombemia e quali sono i sintomi?
La piombemia, termine che indica la concentrazione del metallo nel sangue, è il principale indicatore di un’intossicazione. I sintomi associati possono essere generici e includono stanchezza, sbalzi d’umore, malessere allo stomaco, mal di testa, tremori, perdita di peso e neuropatie. Nei casi più gravi, può provocare anemia, problemi riproduttivi, danni cerebrali, perdita di memoria e, in casi estremi, apoplessia o coma.
Spesso i bambini non mostrano sintomi evidenti subito dopo l’esposizione, ma il rischio di danni permanenti rimane elevato. Per questo motivo, è consigliabile effettuare test nei bambini che presentano segni come ritardi nella crescita, anemia, difficoltà nel linguaggio o deficit di attenzione.
Livelli di esposizione al piombo: la soglia di esposizione
Non esiste una soglia di esposizione considerata sicura. Anche piccole quantità possono causare danni, soprattutto se l’esposizione è prolungata. Un livello di piombo nel sangue pari o superiore a 10 mcg/dL è associato a un aumento del rischio di deficit cognitivi, anche se effetti nocivi sono stati osservati a concentrazioni più basse. Con livelli superiori a 50 mcg/dL, possono manifestarsi sintomi come dolori addominali, stitichezza, tremori e instabilità emotiva. Quando i livelli superano i 100 mcg/dL, il rischio di encefalopatia diventa molto alto.
Come si fa la diagnosi di intossicazione?
La diagnosi di intossicazione non è sempre immediata, poiché i sintomi possono essere vaghi e simili ad altre condizioni. Un esame del sangue per misurare i livelli di piombo è essenziale per confermare il sospetto. Questo può essere accompagnato da test di laboratorio come l’emocromo per valutare l’anemia e la funzionalità renale, insieme a radiografie per individuare eventuali residui di piombo nel corpo.
Nei bambini, è importante testare anche i livelli di ferro, poiché il piombo può interferire con il suo assorbimento. Una carenza di ferro associata a una conta anomala dei globuli rossi può essere un indicatore importante di intossicazione. La diagnosi è confermata quando i livelli di piombo nel sangue superano i 5 mcg/dL.
Esami per monitorare l’esposizione in adulti e bambini
Il test del sangue capillare è uno strumento rapido e relativamente economico per individuare l’esposizione al piombo. Questo esame viene utilizzato sia per diagnosticare nuovi casi sia per monitorare l’efficacia del trattamento. Nei lavoratori esposti al piombo, è utile per valutare il rischio di esposizione cronica e recente. Poiché il piombo può essere trasportato dai luoghi di lavoro all’ambiente domestico tramite abiti o attrezzature, è spesso raccomandato controllare anche i familiari dei lavoratori.
Nei bambini con livelli elevati di piombo nel sangue, è importante esaminare l’ambiente domestico per identificare la fonte dell’esposizione, come vecchie vernici o tubature. In questi casi, un monitoraggio regolare è fondamentale per garantire che i livelli di piombo si riducano nel tempo.
Trattamenti per l’esposizione: quali sono?
In caso di intossicazione da piombo, il trattamento dipende dalla gravità dell’esposizione. Se gli esami radiografici mostrano la presenza di residui di piombo nell’intestino, può essere necessario un lavaggio intestinale con soluzioni specifiche per eliminare il metallo. Nei casi in cui il piombo proviene da proiettili o altri oggetti presenti nel corpo, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per la rimozione.
I pazienti con livelli di piombo nel sangue superiori a 70 mcg/dL o con sintomi neurologici devono essere ricoverati immediatamente. Nei casi più gravi, come quelli con encefalopatia acuta, il ricovero in terapia intensiva è essenziale.
Farmaci specifici, chiamati chelanti, possono essere somministrati per legare il piombo e facilitarne l’eliminazione attraverso le urine. Tuttavia, questi farmaci non sono adatti se l’esposizione al piombo continua, poiché potrebbero aumentare l’assorbimento gastrointestinale del metallo. Nei casi più gravi, possono essere necessari trattamenti ripetuti per ridurre gradualmente la quantità totale di piombo accumulata nell’organismo.
Chi è maggiormente a rischio? Le categorie lavorative a rischio
I lavoratori industriali sono tra i più esposti. Minatori e operai delle fonderie, ad esempio, entrano in contatto diretto con il piombo durante la sua estrazione e lavorazione. Anche negli impianti di riciclo, i rischi sono alti, soprattutto durante il trattamento di batterie e apparecchiature elettroniche.
Nel settore edile, chi lavora alla demolizione o al restauro di vecchi edifici può essere esposto al piombo contenuto nelle vernici o in altri materiali. Anche gli idraulici, specialmente in contesti storici, possono imbattersi in vecchie tubature in piombo.
Altri lavoratori a rischio includono gli artigiani che utilizzano smalti e ceramiche, i tecnici radiologi che manipolano schermi di piombo per proteggersi dalle radiazioni e persino i tiratori sportivi, esposti al metallo contenuto nei proiettili e nei residui di sparo.