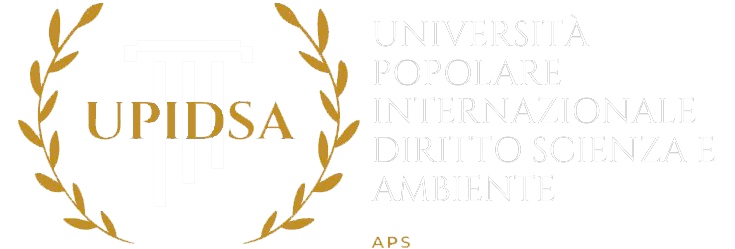In questa guida parliamo di mercurio, una sostanza tossica che causa gravi danni alla salute degli esposti. Alcune categorie professionali sono ad alto rischio di esposizione. L’esposizione però è possibile anche negli ambienti di vita e attraverso l’alimentazione.
Vediamo cos’è il mercurio, quali sono i suoi usi e quali i danni alla salute che provoca nel dettaglio. Vediamo come si fa la diagnosi di intossicazione e cosa fare per proteggersi dall’esposizione dannosa. Vediamo anche quali sono i diritti dei lavoratori esposti e cosa fare se si contrae una malattia correlata.
Contents
- 1 Il Mercurio: cos’è e le proprietà del metallo
- 2 L’Impatto del mercurio sull’ambiente e le cause di inquinamento
- 3 Mercurio: effetti sulla salute e bioaccumulazione
- 4 Normative per ridurre l’inquinamento da mercurio
- 5 Azioni individuali per ridurre le concentrazioni di mercurio: quali?
- 6 La miniera di Monte Amiata: emergenza in toscana
- 7 Mercurio e malattie professionali indennizzabili
- 8 Esposizione professionale: categorie a rischio
Il Mercurio: cos’è e le proprietà del metallo
Anticamente noto come “argento vivo” o “idrargirio”, il mercurio è un metallo particolare che ha catturato l’interesse dell’uomo sin dai tempi più remoti. Il suo simbolo chimico, Hg, deriva dal latino hydrargyrum, a sua volta derivato dal greco hydrárgyros, un termine che combina le parole hydor (acqua) e argyros (argento). Questo nome riflette la sua caratteristica di apparire come un liquido lucente e argenteo a temperatura ambiente.
Il mercurio, infatti, è uno dei pochi metalli che si presenta in forma liquida alle normali temperature terrestri, insieme al copernicio. È un buon conduttore di elettricità ma un pessimo conduttore di calore. La sua solidificazione avviene a circa −38,83 °C, mentre la sua ebollizione avviene a una temperatura relativamente bassa per un metallo, intorno ai 356 °C. Quando è solido, è così morbido che può essere tagliato con un coltello.
L’Impatto del mercurio sull’ambiente e le cause di inquinamento
Questo metallo è presente in natura e si trova su tutto il pianeta, rilasciato nell’ambiente sia attraverso fenomeni naturali come le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi e l’attività geotermica, sia a causa delle attività umane, che sono oggi la principale fonte di emissioni di mercurio. Il mercurio può entrare nell’atmosfera, nel suolo e nelle acque attraverso processi legati all’industria, come la combustione di carbone e la produzione di metalli, o attraverso l’estrazione dell’oro su piccola scala.
Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), enormi quantità di mercurio continuano a essere rilasciate ogni anno a livello globale, specialmente nei paesi al di fuori dell’Europa, dove il suo uso non è vietato. Le principali fonti antropogeniche includono la combustione di combustibili solidi come il carbone, utilizzato per generare elettricità, e l’uso industriale di mercurio per la fabbricazione di cemento, prodotti chimici e metalli. In Europa, grazie a politiche restrittive, le emissioni di mercurio sono state ridotte significativamente negli ultimi decenni.
Il mercurio è estremamente persistente: una volta rilasciato, può rimanere nell’ambiente per migliaia di anni, spostandosi tra l’aria, l’acqua e gli organismi viventi. Questo fenomeno rende la sua gestione particolarmente complessa e il suo impatto ambientale durevole.
I dati più aggiornati sulla situazione attuale dell’inquinamento da mercurio a livello globale possono essere reperiti nel rapporto “Global Mercury Assessment” pubblicato dall’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) del 2018.
L’effetto dei cambiamenti climatici sull’inquinamento
Gli effetti del cambiamento climatico rischiano di peggiorare il problema del mercurio. Le inondazioni possono erodere i terreni e rilasciare mercurio immagazzinato, mentre lo scioglimento del permafrost (il suolo ghiacciato che contiene grandi quantità di mercurio) può liberare ulteriori quantità di questo metallo nell’ambiente.
Anche gli incendi boschivi, in aumento a causa del riscaldamento globale, rilasciano mercurio accumulato nei vegetali. Inoltre, l’aumento delle temperature oceaniche può intensificare la bioaccumulazione del mercurio negli organismi marini, rendendolo ancora più pericoloso per la catena alimentare.
Mercurio: effetti sulla salute e bioaccumulazione
Il mercurio rappresenta una grave minaccia per la salute umana e ambientale. Anche a basse concentrazioni, può causare danni al sistema nervoso centrale, soprattutto nei feti, nei neonati e nei bambini, che sono particolarmente vulnerabili.
Una delle forme più tossiche del mercurio è il metil-mercurio, che tende a bioaccumularsi negli organismi viventi e a concentrarsi lungo la catena alimentare. I pesci predatori di grandi dimensioni, come tonno e pesce spada, accumulano grandi quantità di metil-mercurio, che poi viene ingerito dall’uomo, causando effetti nocivi sulla salute, inclusi problemi alla memoria, al linguaggio e alla capacità di attenzione.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’esposizione al mercurio durante la gravidanza può provocare gravi danni neurologici al feto. Si stima che in Europa ogni anno nascano oltre 1,8 milioni di bambini con livelli di mercurio al di sopra dei limiti di sicurezza.
Effetti del mercurio sulla salute dei bambini
Secondo quanto affermato dall’AEA, il pericolo maggiore per la salute dell’uomo è rappresentato dai pesci, in particolare dal tonno e dal pesce spada, oltre che dai frutti di mare. Infatti, la quantità di mercurio ingerita e accumulata nel tempo da questi grandi pesci viene, poi, assimilata, a tavola, dal corpo umano.
Per l’OMS, la principale preoccupazione è rappresentata dagli effetti dell’idrargirio su feti e bambini. L’esposizione al mercurio può avvenire nell’utero della mamma, con conseguenze pesanti per il bambino, come per esempio “danni alla memoria, al linguaggio, all’attenzione e ad altre abilità”. L’Agenzia stima che solo in Europa ogni anno nascono oltre 1,8 milioni di bambini con livelli di mercurio al di sopra dei limiti di sicurezza. Come già detto, non esistono adeguate evidenze scientifiche che comprovino la correlazione tra esposizione al mercurio e cancro (monografia IARC sul mercurio).
Normative per ridurre l’inquinamento da mercurio
La Conferenza dei Plenipotenziari sulla Convenzione di Minamata sul Mercurio, ratificata da 98 Paesi il 9 ottobre 2013 e entrata in vigore nel 2017, rappresenta un importante passo avanti verso l’adozione di misure globali per ridurre l’inquinamento da mercurio.
Dato l’evidente rischio per la salute legato all’uso del mercurio in odontoiatria, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio hanno raggiunto un accordo. Dal 1° luglio 2018, in Europa non è più consentito utilizzare l’amalgama per le otturazioni dentali dei bambini di età inferiore ai 16 anni e delle donne in gravidanza.
Il ruolo dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sulle esposizioni nocive
Il compito dell’Agenzia Europea dell’Ambiente è raccogliere informazioni sulle emissioni di mercurio nell’aria e nell’acqua provenienti da attività industriali dal Registro Europeo delle Emissioni e dei Trasferimenti di Sostanze Inquinanti (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR). Inoltre, l’Agenzia riporta dati forniti da fonti europee sulle emissioni atmosferiche e sui livelli di inquinamento da mercurio nelle acque, conformemente alla Direttiva quadro sulle acque.
L’Agenzia, che fornisce informazioni sull’ambiente a decision maker e al pubblico, partecipa anche a un programma di biomonitoraggio umano. L’obiettivo del programma è fornire evidenze più convincenti sull’esposizione dei cittadini a sostanze chimiche, tra cui il mercurio, e sui possibili effetti sulla salute.
Questi rapporti servono anche per valutare l’applicazione delle leggi dell’Unione Europea in corso e per sviluppare nuove normative nel settore chimico. Contribuiscono inoltre al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di Minamata.
Azioni internazionali: la Convenzione di Minamata
La consapevolezza dei pericoli legati al mercurio ha portato gli Stati a firmare la Convenzione di Minamata, adottata nel 2013 ed entrata in vigore nel 2017. Questo trattato globale, sottoscritto da 98 paesi, mira a ridurre ed eliminare le emissioni di mercurio causate dalle attività umane. In Europa, sono stati introdotti divieti sull’uso di amalgami dentali contenenti mercurio nei bambini e nelle donne incinte dal 2018.
Azioni individuali per ridurre le concentrazioni di mercurio: quali?
Per minimizzare i rischi associati al mercurio, è possibile adottare alcune precauzioni personali. Ad esempio, è importante seguire i consigli sulla sicurezza alimentare, limitando il consumo di pesce di grandi dimensioni noto per accumulare alti livelli di mercurio. Anche lo smaltimento corretto di rifiuti contenenti mercurio, come lampadine e batterie, è essenziale per ridurre il rilascio di questo metallo nell’ambiente.
Inoltre, passare a fonti di riscaldamento alternative rispetto ai combustibili solidi può contribuire a ridurre le emissioni domestiche di mercurio. Azioni collettive e individuali sono necessarie per affrontare questa sfida globale e proteggere la salute umana e l’ambiente.
La miniera di Monte Amiata: emergenza in toscana
In Italia, uno degli esempi più emblematici dell’impatto del mercurio sull’ambiente e sulla salute è la miniera di mercurio situata sul Monte Amiata, in Toscana. Questa area, un tempo tra i principali centri di estrazione del mercurio a livello mondiale, ha registrato gravi danni ambientali e sanitari a causa delle elevate emissioni di mercurio e dell’esposizione ad altri agenti cancerogeni.
Mercurio e malattie professionali indennizzabili
L’INAIL ha incluso diverse patologie correlate all’esposizione al mercurio nelle tabelle delle malattie professionali indennizzabili. Tra queste troviamo condizioni come la sindrome cerebellare-extrapiramidale, l’encefalopatia tossica, la polineuropatia periferica, la nefropatia e la gengivostomatite.
Queste malattie devono essere riconosciute e indennizzate dall’INAIL per i lavoratori assicurati, sia del settore pubblico che privato, quando l’esposizione al mercurio si verifica nell’ambito lavorativo.
Esposizione professionale: categorie a rischio
L’esposizione professionale al mercurio e ad altri metalli pesanti, come piombo, zinco, rame e cromo, è riconosciuta come una delle principali cause di malattie legate al lavoro. Questo riconoscimento si fonda su normative come l’articolo 1078 del DPR 15 marzo 2010 n. 90, che identifica i metalli pesanti come fattori di rischio per l’insorgenza di patologie tumorali, insieme a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), stabilisce inoltre disposizioni specifiche per il personale militare e civile italiano impiegato in ambienti o condizioni operative particolarmente rischiose. Secondo l’articolo 603, al personale che sviluppa malattie o tumori legati all’esposizione a condizioni ambientali straordinarie è garantito un indennizzo. Questo vale anche per coloro che lavorano in poligoni di tiro, siti di stoccaggio di munizioni o teatri operativi all’estero.
Esposizione a nanoparticelle nei contesti militari
Il DPR n. 90/2010, all’articolo 1078, definisce come particolarmente rischiose alcune condizioni operative. Queste comprendono missioni militari e umanitarie sia in Italia che all’estero, situazioni straordinarie che espongono il personale a rischi superiori alla norma. Tra i fattori di rischio citati vi sono l’esposizione a proiettili all’uranio impoverito e la dispersione di nanoparticelle di metalli pesanti, derivanti dall’esplosione di materiali bellici.
Queste circostanze straordinarie possono causare l’insorgenza di malattie invalidanti o addirittura fatali. La normativa riconosce come aventi diritto alle indennità previste non solo il personale militare e civile direttamente coinvolto, ma anche i loro familiari in caso di decesso, oltre ai cittadini che risiedono in prossimità di basi militari e zone di stoccaggio di munizioni.
Chi ha diritto al riconoscimento della causa di servizio?
Le indennità per le vittime del dovere sono destinate a chi, a causa di particolari condizioni operative o ambientali, sviluppa patologie tumorali o malattie croniche invalidanti. Oltre al personale militare e civile, sono inclusi tra i beneficiari:
- I residenti in aree adiacenti a basi militari o poligoni di tiro.
- I cittadini italiani coinvolti in programmi di cooperazione internazionale o impiegati da ONG in teatri operativi esteri.
- I familiari di lavoratori deceduti per malattie correlate a tali condizioni, inclusi coniugi, figli, genitori e fratelli a carico.
Il concetto di “interdipendenza” è cruciale per il riconoscimento della causa di servizio. Anche in assenza di prove scientifiche definitive sull’effettiva patogenicità di alcuni fattori, come l’uranio impoverito, il diritto all’indennità è riconosciuto se si dimostra che le malattie sono ragionevolmente attribuibili a particolari condizioni ambientali.
Il riconoscimento del Consiglio di Stato
Una sentenza rilevante del Consiglio di Stato (II sezione, n. 5816/2021) ha ulteriormente chiarito che il diritto all’indennizzo non è vincolato alla dimostrazione scientifica definitiva della patogenicità di determinati fattori. Ad esempio, l’esposizione a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti non deve essere necessariamente dimostrata con assoluta certezza per garantire il risarcimento. La semplice correlazione plausibile tra tali esposizioni e lo sviluppo di malattie è sufficiente per riconoscere le prestazioni previste dalla legge.