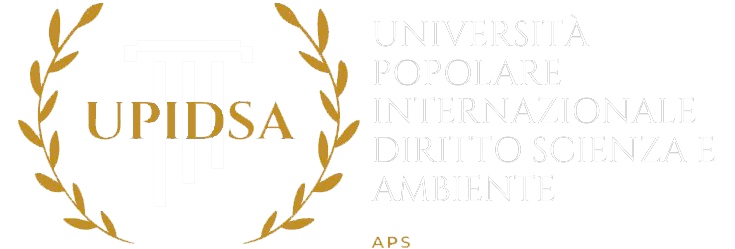Un recente studio italiano propone linee guida per la gestione in sicurezza di manufatti artistici e storici contenenti amianto
Un recente contributo presentato alla Assemblea Generale dell’EGU 2025 porta l’attenzione su un tema ancora poco esplorato ma di crescente interesse. Parliamo della presenza di amianto in oggetti di valore storico, artistico e culturale. Lo studio è intitolato “Amianto nei manufatti del patrimonio culturale: linee guida per la valutazione del rischio e la gestione di manufatti antichi e moderni in vista del restauro, della conservazione e dell’esposizione”. Curato da Gelsomino Rita Petriglieri, Silvana Capella, Fabrizio Siviero ed Elena Belluso, ricercatori dell’Università di Torino e del Centro Interdipartimentale “G. Scansetti”.
La ricerca – disponibile in open access – propone strumenti e metodologie per affrontare con equilibrio una questione complessa. Ossia come preservare il valore dei beni culturali che possono contenere amianto, garantendo al contempo la sicurezza di chi li manipola, conserva o espone.
L’amianto nella storia: un uso antico, una responsabilità moderna
L’impiego dell’amianto nei manufatti risale già al Neolitico. Questo materiale veniva mescolato all’argilla per produrre ceramiche in regioni come la Scandinavia, la Corsica, la Grecia e il Giappone. La sua diffusione prosegue nei secoli. Dai tessuti ignifughi dell’antica Roma ai sudari crematori, fino ai pannelli scenici e strumenti musicali del XX secolo.
L’amianto, grazie alle sue proprietà isolanti, ignifughe e resistenti agli agenti chimici, è stato impiegato per secoli in diverse forme, senza che ne fossero noti gli effetti sulla salute. Solo in epoca recente la comunità scientifica ha stabilito con chiarezza la pericolosità delle fibre di amianto se inalate, portando al suo inserimento tra i cancerogeni umani certi (IARC, 1977) e alla successiva messa al bando in numerosi Paesi.
Leggi a questo link la storia dell’amianto.
Una possibile presenza nei musei e nei depositi
Come evidenziano Petriglieri e colleghi (2025), i materiali contenenti amianto (ACM) non sono limitati agli edifici industriali dismessi. Al contrario, molti oggetti oggi custoditi in musei, fondazioni, collezioni pubbliche o private potrebbero contenere amianto. In forma primaria o secondaria, senza che ciò sia sempre noto o adeguatamente documentato.
Esempi citati includono:
- Dipinti murali e affreschi realizzati con intonaci a base di amianto
- Apparati scenici e sipari teatrali ignifughi
- Pannelli decorativi e strutture modulari del secondo dopoguerra
- Apparecchiature radiofoniche, televisive e cinematografiche d’epoca
- Elementi d’arredo, strumenti musicali e persino flipper
Questi oggetti, spesso esposti al pubblico o movimentati per il restauro, possono, se contenenti amianto, potenzialmente rappresentare un rischio se danneggiati, abrasi o manipolati senza le dovute precauzioni. A causa del possibile rilascio di fibre nell’aria.
Linee guida per la gestione: conservazione e sicurezza possono convivere
Il contributo degli autori non si limita a descrivere il problema, ma propone un approccio operativo e prudente, orientato alla gestione del rischio in modo compatibile con le esigenze della conservazione.
Le principali raccomandazioni includono:
- Analisi preventiva del manufatto, privilegiando metodi non distruttivi
- Valutazione del rischio di esposizione, con attenzione allo stato conservativo e al contesto d’uso
- Formazione specifica degli operatori coinvolti nelle operazioni di restauro, movimentazione o esposizione
- Adozione di misure di contenimento, come la vetrinatura sigillata, ove necessario
- Documentazione accurata della presenza di ACM (materiali contenenti amianto), per ogni opera coinvolta
Le linee guida, formulate secondo criteri scientifici, non impongono bonifiche indiscriminate, né promuovono l’allontanamento sistematico di opere d’arte, ma puntano alla gestione consapevole e informata del rischio, evitando allarmismi o danni al patrimonio.
Un contributo scientifico che potrebbe essere utile al dibattito normativo se confermato
Lo studio, pubblicato con DOI 10.5194/egusphere-egu25-13601, si propone come riferimento per futuri aggiornamenti normativi in materia di amianto nei beni culturali mobili. Attualmente, infatti, le norme vigenti si concentrano sulla presenza di amianto negli edifici, ma in questa ricerca si parla in modo specifico del patrimonio artistico e museale.
Nel rispetto delle norme europee sulla sicurezza e la tutela del patrimonio culturale, gli autori auspicano che questo contributo possa stimolare nuove linee guida tecniche nazionali, coinvolgendo autorità sanitarie, enti culturali, restauratori e professionisti della sicurezza.
Commento dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Nazionale Amianto (ONA)
“La recente pubblicazione rappresenta un interessante interrogativo nella comprensione e nella gestione del rischio amianto anche all’interno del patrimonio culturale. Questa ricerca ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la sicurezza in tutti gli ambiti”.