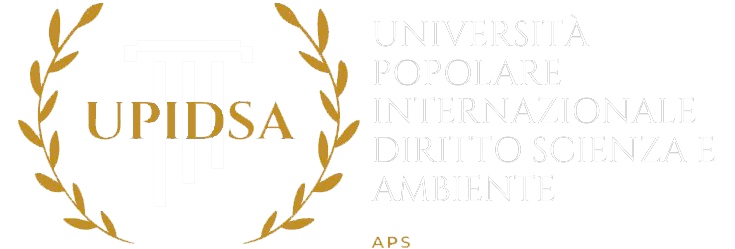In questa guida parliamo del cadmio, un metallo pesante che ha gravi conseguenze sullasalute degli esposti. Vediamo cos’è, dove si trova in natura e dove viene utilizzato. Quindi, quali sono le categorie professionali a rischio e quali sono le tutele legali e le prestazioni economiche per chi sviluppa una malattia correlata. Vediamo in particolare quali sono i danni alla salute e le malattie riconosciute come di origine professionale.
Contents
Che cos’è il cadmio e dove si trova
Il cadmio, indicato con il simbolo chimico Cd e numero atomico 48, è un metallo bianco-argenteo dai riflessi bluastri, con una consistenza così tenera da poter essere tagliato con un coltello. Questo elemento si trova in natura associato ai minerali di zinco, da cui viene estratto come sottoprodotto durante i processi di raffinazione. È inoltre presente, sebbene in quantità minori, in minerali rari come la greenockite (solfuro di cadmio) e l’otavite (carbonato basico di cadmio).
Il cadmio è stato scoperto agli inizi del XIX secolo, ma il suo utilizzo su larga scala è iniziato solo durante la Prima Guerra Mondiale. Prima ancora beniva persino impiegato in ambito medico. Per trattare condizioni come la scrofola e i geloni. Tuttavia, con il progresso scientifico si è compresa la pericolosità di questo metallo, soprattutto per la sua capacità di accumularsi negli organismi e nell’ambiente.
Oggi il cadmio è ampiamente utilizzato in vari settori industriali, tra cui la produzione di batterie al nichel-cadmio, la galvanizzazione dei metalli, la fabbricazione di pigmenti e stabilizzanti per plastiche. Si trova inoltre in alcune leghe metalliche per la saldatura e nei rivestimenti metallici.
Il cadmio è tossico anche a basse concentrazioni e tende ad accumularsi negli organismi e negli ecosistemi.
Il cadmio e i suoi effetti sulla salute umana
Il cadmio è un metallo pesante noto per la sua elevata tossicità, con implicazioni gravi sia per la salute umana che per l’ambiente. Questo elemento chimico può penetrare nel corpo umano attraverso diverse vie di esposizione, sia in ambito lavorativo sia tramite l’ingestione di cibi e acqua contaminati. Un rischio particolare riguarda i militari impiegati in operazioni all’estero o in esercitazioni con munizioni contenenti uranio impoverito: durante le esplosioni, infatti, si generano nanoparticelle di cadmio e altri metalli pesanti che si disperdono nell’ambiente, contaminando suolo, aria e catena alimentare.
Nonostante il suo utilizzo in numerosi processi industriali, il cadmio rappresenta un serio pericolo per la salute a causa della sua capacità di accumularsi nei tessuti biologici e della sua persistenza negli ecosistemi. È quindi fondamentale conoscere i settori professionali a rischio, le normative che regolano l’esposizione e le misure di prevenzione necessarie per minimizzare i danni.
È classificato come un agente cancerogeno di gruppo1 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.
Vie di esposizione al cadmio: quali sono?
Le polveri di cadmio vengono assorbite soprattutto per via inalatoria e in minima parte tramite cute e mucose, quindi è proprio le vie respiratorie che è necessario proteggere per evitare le esposizioni dannose.
Una volta assorbito, il cadmio si lega ai globuli rossi e alle proteine plasmatiche per poi accumularsi nel fegato e nei reni. In questi organi può permanere anche per diversi anni, rendendo difficile il monitoraggio biologico dell’esposizione acuta. Una volta depositato, lo smaltimento avviene assai lentamente attraverso le feci e le urine.
Rischi per la salute nel dettaglio: quali sono?
Come già detto, il cadmio è classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno di Gruppo 1, ovvero tra le sostanze con evidenza sufficiente di cancerogenicità per l’uomo. Qui è possibile trovare la monografia sul cadmio che riporta studi che lo correlano al cancro ai polmoni, prostata, fegato, pancreas, seno, vescica ed endometrio.
I disturbi associati a questa sostanza comprendono:
- Danni renali: il cadmio si accumula nei reni, compromettendone la funzionalità e causando insufficienza renale nei casi più gravi.
- Problemi ossei: l’esposizione cronica può portare a demineralizzazione e fratture spontanee.
- Cancro: l’associazione con tumori al polmone, prostata, fegato e pancreas è ben documentata.
- Disturbi metabolici e riproduttivi: il cadmio interferisce con il metabolismo cellulare e può compromettere la fertilità maschile e femminile.
Un esempio emblematico delle conseguenze dell’intossicazione da cadmio è la malattia “itai-itai”, che colpì la popolazione giapponese all’inizio del XX secolo a causa dello scarico di metalli pesanti nei fiumi. Questo ha causato gravi fragilità ossee e insufficienza renale. “Itai” significa “doloroso” in giapponese, riferendosi ai forti dolori alle ossa e alla colonna vertebrale.
Esposizione alimentare e idrica: come funziona?
L’esposizione al cadmio attraverso il consumo di acqua e cibo è una delle principali fonti di contaminazione per la popolazione generale. Infatti può infiltrarsi nell’acqua potabile attraverso impianti idrici che contengono zinco galvanizzato o saldature di cadmio. L’acqua dolce con basso pH tende a favorire la corrosione delle condutture, aumentando la concentrazione di cadmio.
Secondo le stime, il consumo quotidiano di cadmio tramite l’alimentazione varia tra i 10 e i 35 microgrammi. L’esposizione attraverso l’acqua potabile è generalmente più bassa, intorno ai 2 microgrammi al giorno. Tuttavia, per i fumatori, l’assunzione può aumentare significativamente: una persona che fuma un pacchetto di sigarette al giorno può introdurre nel proprio organismo altri 2-4 microgrammi di cadmio.
Meccanismo e sintomi dell’intossicazione da cadmio
Una volta entrato nel flusso sanguigno, il cadmio si lega principalmente alla metallotioneina, una proteina ricca di gruppi sulfidrilici. Questo legame consente al cadmio di essere filtrato a livello glomerulare e successivamente riassorbito dalle cellule del tubulo prossimale del rene, dove esercita un’azione tossica. Questo processo di riassorbimento spiega perché, nelle fasi iniziali dell’esposizione, il cadmio presente nelle urine è in quantità ridotta, sebbene il fenomeno dell’escrezione sia comunque rilevante. Tuttavia, una prolungata esposizione al metallo conduce a un danno progressivo alle cellule tubulari renali, compromettendo la capacità del rene di riassorbire il cadmio e causando tossicità sistemica.
L’inalazione di polveri contenenti cadmio rappresenta una delle vie di esposizione più pericolose: concentrazioni pari a 5 mg/m³ possono risultare letali nel giro di otto ore, mentre esposizioni di 1 mg/m³ provocano gravi effetti respiratori, tra cui difficoltà a respirare (dispnea), tosse persistente, febbre e stanchezza cronica. Quando l’assunzione avviene per via alimentare, attraverso cibi contaminati, possono manifestarsi disturbi gastrointestinali, quali nausea, diarrea, vomito e grave disidratazione.
Rilevazione del cadmio e impatti sulla salute
Il parametro principale per valutare l’esposizione al cadmio è la sua concentrazione nelle urine, nota come cadmiuria. Come già descritto, il cadmio urinario riflette l’assorbimento nelle prime fasi dell’intossicazione, così come il danno renale indotto dal metallo. Tuttavia, a causa della tendenza del cadmio ad accumularsi nei tessuti renali e epatici, i livelli urinari possono rimanere elevati anche a distanza di molto tempo dalla cessazione dell’esposizione. Per questa ragione, la cadmiuria è considerata un indicatore valido solo se accompagnata da un’attenta ricostruzione della storia lavorativa e ambientale del soggetto.
Il danno renale cronico associato al cadmio si manifesta spesso con un’aumentata escrezione urinaria di proteine a basso peso molecolare, un fenomeno noto come proteinuria. Questo segno è indicativo di un danno significativo alle cellule tubulari renali e persiste anche dopo l’interruzione dell’esposizione al metallo. Quando la proteinuria resta elevata nel tempo, si sospetta un danno renale irreversibile, tipico delle esposizioni prolungate.
La conoscenza degli indicatori di esposizione e dei meccanismi di tossicità è cruciale per identificare precocemente i casi di avvelenamento, adottare interventi mirati e prevenire complicazioni a lungo termine.
Categorie professionali a rischio: quali sono?
Alcune categorie lavorative sono particolarmente esposte al cadmio a causa delle condizioni professionali. Tra queste, troviamo i lavoratori impiegati nella produzione di batterie, nei processi di galvanizzazione, nella fabbricazione di pigmenti e nella saldatura di leghe contenenti cadmio. Anche il settore militare rappresenta un ambito ad alto rischio: l’uso di munizioni all’uranio impoverito durante esercitazioni o missioni all’estero rilascia nanoparticelle di cadmio e altri metalli pesanti, contaminando l’ambiente e causando gravi conseguenze per la salute.
Cadmio e uranio impoverito nel dettaglio
Come già accennato l’esposizione al cadmio e a altri metalli pesanti è connessa anche all’utilizzo di munizioni all’uranio impoverito. Questo metallo radioattivo e altamente denso ha un potere perforante particolarmente alto. Durante la denotazione i proiettili e i target centrati rilasciano nanoparticelle di metalli pesanti, tra cui può essere presente il cadmio.
I militari italiani impiegati nelle guerre in Kosovo, in Libano e in Iraq e in alcune esercitazioni hanno riportato gravi malattie connesse all’esposizione a metalli pesanti, tra cui la Sensibilità Chimica Multipla. Citiamo brevemente il caso del Colonnello Calcagni, contaminato da 28 metalli pesanti durante le missioni svolte nei teatri di guerra in cui veniva usato l’uranio impoverito, intervenuto nel corso della quinta puntata di ONA TV.
Normativa e limiti di esposizione
La normativa europea ha stabilito limiti rigorosi per la presenza di cadmio negli alimenti e nell’acqua potabile. Il regolamento CE 1881/04, aggiornato da successive normative, stabilisce i livelli massimi di concentrazione consentiti nei prodotti alimentari, mentre il Decreto Legislativo italiano 31/2001 impone un limite di 5 microgrammi per litro per l’acqua potabile.
In ambito lavorativo, il cadmio è incluso tra i metalli pesanti regolamentati, con limiti di esposizione definiti per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), l’esposizione media degli adulti europei al cadmio si avvicina o supera leggermente la dose tollerabile. Inoltre, per alcuni gruppi di consumatori come vegetariani, vegani, bambini e persone che vivono in aree particolarmente contaminate, i livelli di assunzione possono raggiungere il doppio della dose tollerabile.
Già nel 2014 sono stati stabiliti nuovi limiti per gli alimenti destinati a lattanti e bambini, per il cioccolato e per i prodotti a base di cacao. Per altri alimenti è stata adottata una strategia di “riduzione graduale” attraverso l’implementazione di metodi di mitigazione. Questa strategia ha dimostrato che è possibile ridurre le concentrazioni di cadmio, e quindi sono stati introdotti nuovi limiti.
Dose di cadmio nell’acqua secondo l’OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito un valore guida di 3 μg/L per il cadmio nell’acqua. Il Decreto Legislativo 31/2001 ha fissato un valore limite di 5,0 μg/L per l’acqua potabile. Attraverso processi di coagulazione o precipitazione, è possibile raggiungere una concentrazione di 0,002 mg/L di cadmio nell’acqua destinata al consumo umano.
Prevenzione dell’esposizione al cadmio
La prevenzione dell’esposizione al cadmio si articola in tre livelli:
- Primaria: evitare il contatto con il metallo tramite l’uso di dispositivi di protezione personale e impianti di ventilazione adeguati.
- Secondaria: monitorare regolarmente i lavoratori a rischio attraverso esami medici specifici e valutazioni ambientali.
- Terziaria: fornire assistenza legale e medica ai lavoratori che hanno già subito danni, garantendo risarcimenti e prevenendo ulteriori esposizioni.
Riconoscimento delle malattie professionali
L’INAIL riconosce diverse patologie legate all’esposizione al cadmio, tra cui broncopneumopatia cronica ostruttiva, nefropatia tubulare e tumori polmonari. Le malattie incluse nella Lista I dell’INAIL sono considerate ad alta probabilità di origine professionale e non richiedono ulteriori prove di causalità. Tuttavia, per le patologie della Lista II, il lavoratore deve dimostrare il nesso causale tra l’esposizione e la malattia.
Eccole di seguito:
- Broncopneumopatia cronica ostruttiva (J68.4), elencata nella Lista I dell’INAIL come malattia ad alta probabilità di origine professionale e indennizzabile dall’INAIL per un massimo di 6 anni dopo la fine dell’esposizione lavorativa.
- Nefropatia tubulare (N14.3), elencata nella Lista I e indennizzabile per un massimo di 3 anni.
- Osteomalacia (M83), elencata nella Lista I e indennizzabile per un massimo di 6 anni.
- Cancro del polmone (C34), sempre nella Lista I e indennizzabile per un periodo illimitato.
- Tumore della prostata, inserito nella Lista II dell’INAIL, indennizzabile per un periodo massimo illimitato.
- Riniti, rinofaringiti e faringiti croniche, elencate nella Lista I dell’INAIL e indennizzabili per 3 anni.
- Altre malattie correlate all’esposizione al cadmio e ai suoi composti.
L’assistenza legale fornita da enti come l’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) è fondamentale per garantire il riconoscimento dei diritti e l’ottenimento di risarcimenti adeguati: rendita o indennizzo INAIL, causa di servizio ed equo indennizzo, risarcimento integrale dei danni a carico del datore di lavoro che non ha rispettato le norme di sicurezza.